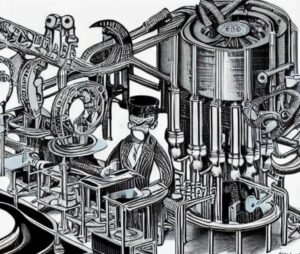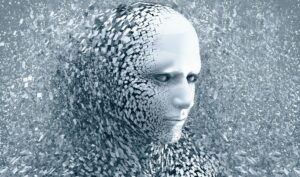Cultura della tecnica
A lungo la techne è stata considerata lo strumento con cui compensare una natura incompleta, con cui emanciparsi dai limiti biologici ed espandere le potenzialità umane oltre i confini della propria pelle.
Mentre la tradizione ha interpretato gli altri animali come compiuti nelle loro caratteristiche specie-specifiche, l’essere umano è stato inteso come “nudo” e pertanto necessitante dell’intervento di strumenti esterni atti a garantirgli la sopravvivenza.
Questo apporto esterno è stato inteso come un vero e proprio potenziamento, dove il corpo rimane invariato e lo strumento funge da stampella potenziativa.
In questo potenziamento, l’essere umano non ha limiti di sorta, proprio perché non è più vincolato ad alcuna matrice materiale: può liberamente esprimere sé stesso, espandersi in ogni direzione, acquisire le capacità di comprensione e manipolazione di qualsiasi entità. La cultura, dunque, intesa come insieme delle manifestazioni razionali, creative e artigianali della specie umana, esonera e compensa il corpo che rimane, invece, in uno stato embrionale.
Il pensiero postumanista rifiuta una simile lettura. La techne non è inerte e neutrale rispetto all’utilizzo che se ne fa; non rappresenta una marionetta governata dalla volontà umana che, chiusa nella sua cabina di comando, progetta e dirige il suo percorso di sviluppo. La techne è pervasiva.
Essa retroagisce sulle coordinate morfo-funzionali umane, rimodellandole e riorganizzandole. In parole semplici, trasforma l’architettura del corpo così come il diffondersi della luce influenza la chioma degli alberi.
La retroazione avviene attraverso uno slittamento delle pressioni selettive e un conseguente impatto sulla fitness e sullo standard genotipico della popolazione, cioè sui caratteri genetici e sull’aspetto che tendenzialmente quella specie avrà.
Ammettere una retroazione della techne sul corpo, implica abbandonare l’idea che questa sia uno strumento inerte nelle nostre mani e forgiato dai nostri sogni, ossia che non abbia alcuna influenza sul nostro comportamento, sul nostro stile di vita, oltre che sulla nostra struttura biologica.
Al contrario, l’avvento di qualsiasi apparecchio tecnologico, equivalendo all’introduzione di un nuovo partner ibridativo, costituisce sempre una tecno-poiesi, cioè una ricalibratura di come ci interfacciamo al mondo, di cosa significhi essere umano e di quali siano le sue capacità operative.
Un discorso analogo vale tout court per la tecnologia che «più che a un coinquilino portatore di probiosi, ricorda un virus in grado di penetrare la cellula (i predicati somatici) e di riorganizzare il metabolismo degli esseri umani e del criterio di efficacia delle loro azioni» (Marchesini, Tecnosfera, p. 197).