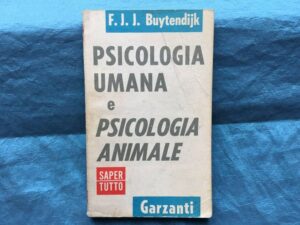Cittadinanza e società
Il postumanismo intende inaugurare una trasformazione epocale, partendo dagli aspetti educativi e di cittadinanza, al fine di promuovere un nuovo modello esistenziale: un modello basato sulla convivenza e sulla partecipazione conviviale, al posto della prevalenza della realizzazione individuale e dell’affermazione dell’uomo sulla natura. Come s’è detto, si tratta di una rivoluzione valoriale che opera uno slittamento non solo nel modo di condurre la vita come convivio, ma anche di riconoscere nuove finalità per l’individuo e altrettanto innovativi modelli sociali di convivenza. Anche nel caso del progetto postumanistico si tratta di costruire le opportunità perché questo uomo nuovo possa fiorire, lasciandosi alle spalle quelle tendenze che lo condannavano alla solitudine e all’ostilità nei confronti delle alterità, quale sentimento di rivincita rispetto a una sofferenza interiore. Il punto centrale di questa metamorfosi è l’abbandono dell’individualismo competitivo e del ripiegamento solipsistico esistenziale, assumendo nuovi significati alla propria presenza incentrati sull’apertura e sulla partecipazione: in una parola sull’orizzontalità del soggetto che riscopre un senso alla sua esistenza allargando le braccia sul mondo. Per tale motivo non possiamo pensare il postumanismo senza un coinvolgimento progettuale.
Se analizziamo il precetto umanistico della verticalizzazione rispetto alla natura scopriamo che questa direttrice non si limita all’ambito teoretico, ma trova una traduzione nella vita di tutti i giorni che vede la prevalenza dell’artificiale, l’incentivazione antropoplastica, la preferenza del lavoro immateriale. La separazione dalla terra nella quotidianità delle persone ha prodotto un distacco dalla natura, un deficit di familiarità con le dimensioni della vivente, una profonda ignoranza di tutto ciò che concerne le alterità animali e vegetali. Questa separazione è alla base della negligenza – una forma di dimenticanza affettiva – che osserviamo nei confronti della distruzione ecologica in atto, perché fondata su una diseducazione sentimentale che, inevitabilmente, cambia l’assetto valoriale e quindi le priorità delle persone. E la disgiunzione non sta solo nella disattenzione e nella preferenza dei prodotti dell’uomo, ma anche nella visione oleografica e quindi statica e disgiunta della natura, quale si può rilevare nel conservatorismo o in talune espressioni di neoluddismo o di nostalgia verso un passato selvaggio e mitologico. Per il postumanismo, l’essere umano vive in una dimensione metamorfica e dinamica che lo include attraverso riti di contaminazione che, al contrario di quelli umanistici di purificazione, si basano sullo sporcarsi di terra e di allargare il proprio orizzonte sui fenomeni naturali e sull’ibridazione.
Ma per far questo è necessario costruire un nuovo modello di vita che liberi il soggetto da tutti quei condizionamenti che hanno caratterizzato la civiltà umanista, come la competizione sfrenata tra le persone e il bisogno di circondarsi di apparati di senso gravitanti sull’individuo e incentivanti la sua solitudine. Siamo immersi in un modello economico-produttivo totalmente adulterato, potremmo dire addirittura drogato, che si regge sulla prigione esistenziale di un Sé apparentemente maiuscolo, in realtà schiavizzato dall’alienazione del lavoro – il lavoro ha perduto di senso esistenziale per trasformarsi in mercificazione dell’individuo e collocazione all’interno del sistema – e dal consumismo, in un’idea di economia circolare che non fa altro che accrescere le sperequazioni spacciando l’illusione dell’autorealizzazione. Questa società costringe l’individuo al ruolo di spettatore, perché gli nega gli spazi privati e lo illude di poter essere protagonista di palcoscenici globali che, però, non gli appartengono, costringendolo ad acquistare titoli di promozione, come le pubblicazioni, la visibilità, i follower, il denaro o il prestigio. La logica dell’equilibrio di domanda e offerta alimenta la falsa idea di un saldo implicito e di una titolarità d’acquisto, quando è ormai chiaro che il modello non risponde al benessere della persona, perché porta a mercificare prima di tutto l’essere umano, e soprattutto si basa su meccanismi di retroazione positiva favorendo così le diseguaglianze e il contrasto sociale.
Occorre costruire un’economia per le persone, non il contrario, al fine di realizzare quelle opportunità che consentono a ciascuno una crescita affettivamente solida oltre che appagante. L’esasperazione umanista, vale a dire il portare all’estreme conseguenze i precetti che ho discusso, rappresenta a tutti gli effetti una psicopatologia, perché nega alla persona una corretta crescita. La collocazione forzosa all’interno di un sistema non appagante, fondato su continui processi surrogativi e su meccanismi di doping, porta a un processo d’infantilizzazione del soggetto che rimane sospeso in un limbo che lo espone ad ansie e compulsioni proprio per la struttura derivale che implica. Il progetto umanista poteva reggere nei primi secoli, quando ancora le società non avevano raggiunto quel livello di complessità che oggi vediamo e di concerto la tecnologia non aveva completamente distaccato l’essere umano dalla terra. Oggi questo processo ha assunto un andamento così pervasivo da mettere in evidenza gli aspetti perversi, tossici e contraddittori. Il progetto postumanista diventa, allora, una necessità non solo per rispondere alla crisi ecologica, alla perdita di senso, alle sfide che lo sviluppo tecnologico ci pone, ma per liberare l’essere umano dalla prigione che egli stesso si è costruito finendo intrappolato in un meccanismo che lo sta stritolando.